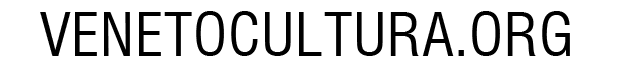IL RUDERE DELL'ANTICA CASA COLONICA RACCONTA
Sulla zona dove fioriva il verde rigoglioso, ora si è imposto l'arido espandersi della cementificazione e l'antica casa colonica ivi ubicata, ormai abbandonata e in rovina, cade pezzo dopo pezzo, soffocata dall'assedio di nuove costruzioni. Da alcune tipiche tracce architettoniche ancora visibili, si intuisce che essa possa essere sorta, in tempi remoti, come cenobio di monaci oranti ed operosi, al centro della vasta plaga da essi poi dissodata. Ciò sembra confermato anche da qualche segno sbiadito di vetusti affreschi sacri rimasto su qualche muro cadente.
E' facile capire che quel luogo fosse il centro propulsore che, all'insegna della massima "ora et labora", rese fertile tutto il territorio circostante. In seguito, per sconosciute vicende, quell'edificio si trasformò in una grande casa colonica che, per secoli e secoli, ospitò generazioni di patriarcali famiglie contadine. Questo rudere agonizzante sembra ora emettere una flebile eco di dolci salmodie gregoriane come triste viatico ma, prima che tutto si spenga, vuol raccontare, quasi voce della moltitudine di esistenze che qui sono passate, la vita che vi si è avvicendata nel tempo. Racconta che il lavoro dei campi era talvolta così duro da spezzare la schiena, ma era sempre svolto con zelo e sagacia confidando nella protezione divina affinché la terra, lavorata con attaccamento sacrale, ricambiasse con abbondanti raccolti. Momenti salienti del lavoro agricolo erano la cura del bestiame, la semina, la fienagione, la mietitura, la vendemmia con le rispettive fasi connesse. Nella stagione invernale riservata al riposo della campagna, i contadini si dedicavano alla costruzione e riparazione degli attrezzi indispensabili al loro lavoro. La fattoria era come un microcosmo che si completava e concludeva in sé stesso, basato sul lavoro e la determinazione concorde delle decine di familiari dei nuclei componenti che, riuniti sotto l'egida del vecchio patriarca attorno al grande desco dell'enorme cucina fumosa, durante i pasti frugali, concordavano gli interventi da realizzare e si dividevano i compiti operativi. Il tutto sulla base di un rapporto simbiotico con la natura e in sintonia con l'evolversi delle stagioni.
La sussistenza alimentare era assicurata dai prodotti della terra (in primis il mais, allora detto granturco, con cui si faceva la polenta, alimento base del loro regime gastronomico, ma poi ortaggi vari, vino, ecc.), dai prodotti della stalla (latte e derivati), del pollaio (uova e carni), dall'allevamento di qualche maiale (insaccati e grassi) e di pecore di cui si utilizzava la lana. La concimazione dei campi con lo stallatico garantiva una fertilizzazione naturale con conseguente genuinità dei prodotti. Caratteristica fondamentale di questa gente era il senso religioso che impostava la vita sulla fede nell'Assoluto (il "Paron del Mondo") e regolava tutte le fasi della vita, dalla nascita fino alla morte. Da ricordare come partecipassero, a maggio, alle "rogazioni" che erano delle processioni attraverso i campi, per invocare la protezione divina e dei Santi sulle coltivazioni. Altro evento sacrale caratteristico era il "panevin", che consisteva in un enorme falò che veniva acceso dopo aver asperso la ramaglia con l'acquasanta, nella notte dell'Epifania allorché tutti affidavano un intimo pensiero alle alte fiammate perché, con la loro veemenza ascensionale, portassero speranze e attese fino al Trono Celeste. Dalla direzione del fumo si traevano poi i presagi per i futuri raccolti. Ma una prerogativa fondamentale di quel mondo era il forte senso di umana solidarietà: molteplici erano gli interventi che ne erano impregnati. Da ricordarne alcuni. Se, ad esempio, una famiglia, per malattia di qualche suo componente od altro, non poteva far fronte ai lavori agricoli indilazionabili,i vicini si prestavano gratuitamente alla bisogna e se, in qualche raro caso, dei bambini restavano orfani dei genitori e senza parenti, altre famiglie se ne prendevano carico.
Ai numerosi montanari, qualche volta anche donne assieme ai figlioletti, che d'inverno scendevano in pianura trascinando un capace carretto carico di utensili vari di legno da essi intagliati, che offrivano in cambio di granella di mais, oppure che venivano a prestare la loro opera di seggiolai, le famiglie contadine offrivano vitto e alloggio per la notte e spesso trascorrevano lunghe serate dei "filò" attorno a questi ospiti per ascoltarne i racconti di fatti e avvenimenti di cui costoro, quasi precursori dei moderni reporter, venivano a conoscenza nel loro continuo peregrinare di paese in paese, di casa in casa. Se, talvolta, nella brutta stagione, passava qualche pastore transumante col gregge, gli veniva offerta sia pur breve ospitalità dandogli così modo di assaporare un po' di calore domestico nel continuo errare fra monti e pianura. Soprattutto era radicato il senso di vicinanza agli anziani che, nel declino delle forze, venivano amorevolmente assistiti dai parenti, nell'ambito familiare, fino al trapasso.
Quelle pietre ricordano anche che alla gente di campagna, nel pesante ritmo lavorativo, non mancavano parentesi distensive. Tra queste, da ricordare i dopocena sull'aia nelle torride estati dopo le estenuanti fatiche. Erano momenti magici, ora irripetibili, fatti di uno splendido cielo stellato palpitante di infinito, di una dolce brezza odorosa di aromi campestri, del canto solitario dalle mille modulazioni dell'usignolo sul sottofondo di cori lontani di raganelle, in un'atmosfera arcana in cui pareva di poter cogliere il respiro dell'universo. Così si poteva sedare la spossatezza del giorno e prepararsi al sonno ristoratore della notte. Ricordano pure come i ragazzi, pur nella totale carenza di mezzi, trovavano modo di assaporare ed esternare tutta la prorompente gioia di vivere nei semplici giochi quali il "pantocco" per le ragazze e, per i maschi, quelli della "momola", della "bissaboa", del "pito" e dello "slitolar" sul ghiaccio dei fossati d'inverno, talvolta così spesso che, frequentemente ,veniva stagliato in blocchi con la scure per fornire le ghiacciaie in città. A capodanno si recavano di casa in casa a porgere gli auguri in cambio di qualche monetina che andava ad arricchire il piccolo gruzzolo personale nel salvadanaio di terracotta. Il martedì grasso passavano ancora di famiglia in famiglia camuffati nei modi più buffi, facendo scherzi e burle per ricevere "crostoli"e frittelle in cambio dell'allegria che dispensavano. I più grandicelli giocavano a calcio con palle di pezza, oppure, d'estate andavano a diguazzare più che a nuotare, nei numerosi fossati vicini. Le rovine parlano anche degli eloquenti, succosi proverbi tramandati di generazione in generazione, un vero concentrato di sapienza e arguzia contadine attinente alla composita realtà esistenziale.
Ora questo rudere, residuo di quelle mura tra le quali, nei secoli, infinite volte è sbocciata la vita ed è passata la morte, scrigno di un autentico patrimonio di fondamentali valori e ancestrali tradizioni, scompare portando con sé nell'oblio quella civiltà contadina di cui è stato simbolo significativo. Ad essa è subentrata la nuova civiltà tecnologica della quale, il grande centro commerciale che, pare, starebbe per sorgere su quelle rovine, sarebbe uno degli emblemi più eclatanti. Non si può comunque disconoscere l'apporto umano dell'infinita miriade di quanti ci hanno preceduto nei tempi passati che, con una vita fatta di lavoro, onestà, parsimonia, privazioni, solidarietà, hanno contribuito a costruire le premesse dello sviluppo di cui tutti ora beneficiamo, lasciandoci una grande eredità morale.
Lino Spigariol
Sulla zona dove fioriva il verde rigoglioso, ora si è imposto l'arido espandersi della cementificazione e l'antica casa colonica ivi ubicata, ormai abbandonata e in rovina, cade pezzo dopo pezzo, soffocata dall'assedio di nuove costruzioni. Da alcune tipiche tracce architettoniche ancora visibili, si intuisce che essa possa essere sorta, in tempi remoti, come cenobio di monaci oranti ed operosi, al centro della vasta plaga da essi poi dissodata. Ciò sembra confermato anche da qualche segno sbiadito di vetusti affreschi sacri rimasto su qualche muro cadente.
E' facile capire che quel luogo fosse il centro propulsore che, all'insegna della massima "ora et labora", rese fertile tutto il territorio circostante. In seguito, per sconosciute vicende, quell'edificio si trasformò in una grande casa colonica che, per secoli e secoli, ospitò generazioni di patriarcali famiglie contadine. Questo rudere agonizzante sembra ora emettere una flebile eco di dolci salmodie gregoriane come triste viatico ma, prima che tutto si spenga, vuol raccontare, quasi voce della moltitudine di esistenze che qui sono passate, la vita che vi si è avvicendata nel tempo. Racconta che il lavoro dei campi era talvolta così duro da spezzare la schiena, ma era sempre svolto con zelo e sagacia confidando nella protezione divina affinché la terra, lavorata con attaccamento sacrale, ricambiasse con abbondanti raccolti. Momenti salienti del lavoro agricolo erano la cura del bestiame, la semina, la fienagione, la mietitura, la vendemmia con le rispettive fasi connesse. Nella stagione invernale riservata al riposo della campagna, i contadini si dedicavano alla costruzione e riparazione degli attrezzi indispensabili al loro lavoro. La fattoria era come un microcosmo che si completava e concludeva in sé stesso, basato sul lavoro e la determinazione concorde delle decine di familiari dei nuclei componenti che, riuniti sotto l'egida del vecchio patriarca attorno al grande desco dell'enorme cucina fumosa, durante i pasti frugali, concordavano gli interventi da realizzare e si dividevano i compiti operativi. Il tutto sulla base di un rapporto simbiotico con la natura e in sintonia con l'evolversi delle stagioni.
La sussistenza alimentare era assicurata dai prodotti della terra (in primis il mais, allora detto granturco, con cui si faceva la polenta, alimento base del loro regime gastronomico, ma poi ortaggi vari, vino, ecc.), dai prodotti della stalla (latte e derivati), del pollaio (uova e carni), dall'allevamento di qualche maiale (insaccati e grassi) e di pecore di cui si utilizzava la lana. La concimazione dei campi con lo stallatico garantiva una fertilizzazione naturale con conseguente genuinità dei prodotti. Caratteristica fondamentale di questa gente era il senso religioso che impostava la vita sulla fede nell'Assoluto (il "Paron del Mondo") e regolava tutte le fasi della vita, dalla nascita fino alla morte. Da ricordare come partecipassero, a maggio, alle "rogazioni" che erano delle processioni attraverso i campi, per invocare la protezione divina e dei Santi sulle coltivazioni. Altro evento sacrale caratteristico era il "panevin", che consisteva in un enorme falò che veniva acceso dopo aver asperso la ramaglia con l'acquasanta, nella notte dell'Epifania allorché tutti affidavano un intimo pensiero alle alte fiammate perché, con la loro veemenza ascensionale, portassero speranze e attese fino al Trono Celeste. Dalla direzione del fumo si traevano poi i presagi per i futuri raccolti. Ma una prerogativa fondamentale di quel mondo era il forte senso di umana solidarietà: molteplici erano gli interventi che ne erano impregnati. Da ricordarne alcuni. Se, ad esempio, una famiglia, per malattia di qualche suo componente od altro, non poteva far fronte ai lavori agricoli indilazionabili,i vicini si prestavano gratuitamente alla bisogna e se, in qualche raro caso, dei bambini restavano orfani dei genitori e senza parenti, altre famiglie se ne prendevano carico.
Ai numerosi montanari, qualche volta anche donne assieme ai figlioletti, che d'inverno scendevano in pianura trascinando un capace carretto carico di utensili vari di legno da essi intagliati, che offrivano in cambio di granella di mais, oppure che venivano a prestare la loro opera di seggiolai, le famiglie contadine offrivano vitto e alloggio per la notte e spesso trascorrevano lunghe serate dei "filò" attorno a questi ospiti per ascoltarne i racconti di fatti e avvenimenti di cui costoro, quasi precursori dei moderni reporter, venivano a conoscenza nel loro continuo peregrinare di paese in paese, di casa in casa. Se, talvolta, nella brutta stagione, passava qualche pastore transumante col gregge, gli veniva offerta sia pur breve ospitalità dandogli così modo di assaporare un po' di calore domestico nel continuo errare fra monti e pianura. Soprattutto era radicato il senso di vicinanza agli anziani che, nel declino delle forze, venivano amorevolmente assistiti dai parenti, nell'ambito familiare, fino al trapasso.
Quelle pietre ricordano anche che alla gente di campagna, nel pesante ritmo lavorativo, non mancavano parentesi distensive. Tra queste, da ricordare i dopocena sull'aia nelle torride estati dopo le estenuanti fatiche. Erano momenti magici, ora irripetibili, fatti di uno splendido cielo stellato palpitante di infinito, di una dolce brezza odorosa di aromi campestri, del canto solitario dalle mille modulazioni dell'usignolo sul sottofondo di cori lontani di raganelle, in un'atmosfera arcana in cui pareva di poter cogliere il respiro dell'universo. Così si poteva sedare la spossatezza del giorno e prepararsi al sonno ristoratore della notte. Ricordano pure come i ragazzi, pur nella totale carenza di mezzi, trovavano modo di assaporare ed esternare tutta la prorompente gioia di vivere nei semplici giochi quali il "pantocco" per le ragazze e, per i maschi, quelli della "momola", della "bissaboa", del "pito" e dello "slitolar" sul ghiaccio dei fossati d'inverno, talvolta così spesso che, frequentemente ,veniva stagliato in blocchi con la scure per fornire le ghiacciaie in città. A capodanno si recavano di casa in casa a porgere gli auguri in cambio di qualche monetina che andava ad arricchire il piccolo gruzzolo personale nel salvadanaio di terracotta. Il martedì grasso passavano ancora di famiglia in famiglia camuffati nei modi più buffi, facendo scherzi e burle per ricevere "crostoli"e frittelle in cambio dell'allegria che dispensavano. I più grandicelli giocavano a calcio con palle di pezza, oppure, d'estate andavano a diguazzare più che a nuotare, nei numerosi fossati vicini. Le rovine parlano anche degli eloquenti, succosi proverbi tramandati di generazione in generazione, un vero concentrato di sapienza e arguzia contadine attinente alla composita realtà esistenziale.
Ora questo rudere, residuo di quelle mura tra le quali, nei secoli, infinite volte è sbocciata la vita ed è passata la morte, scrigno di un autentico patrimonio di fondamentali valori e ancestrali tradizioni, scompare portando con sé nell'oblio quella civiltà contadina di cui è stato simbolo significativo. Ad essa è subentrata la nuova civiltà tecnologica della quale, il grande centro commerciale che, pare, starebbe per sorgere su quelle rovine, sarebbe uno degli emblemi più eclatanti. Non si può comunque disconoscere l'apporto umano dell'infinita miriade di quanti ci hanno preceduto nei tempi passati che, con una vita fatta di lavoro, onestà, parsimonia, privazioni, solidarietà, hanno contribuito a costruire le premesse dello sviluppo di cui tutti ora beneficiamo, lasciandoci una grande eredità morale.
Lino Spigariol